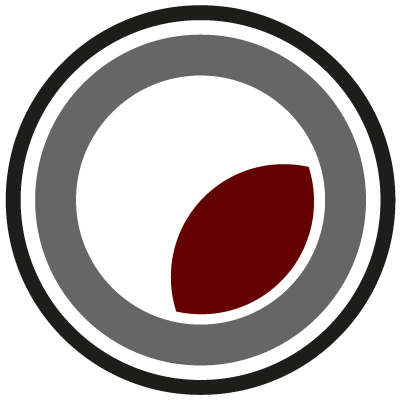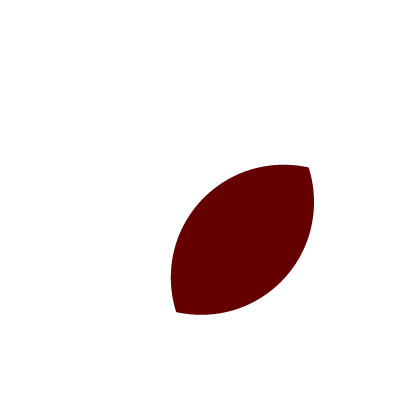Ho dei parametri e la mia vita a questo punto è paragonabile ai sedimenti di una vecchia tazza da caffè e vorrei piuttosto morire giovane, preservando ciò che è stato fatto, anzichè cancellare confusamente tutte queste cose delicate.
Francesca Woodman
La prima impressione che ti assale osservando i lavori di Francesca Woodman è quella di ritrovarci rimandi a Man Ray o Duane Michals, di riconoscervi i tratti noir dello stile di Weegee o di Jan Saudek. Questa geniale e irrequieta fotografa americana, scomparsa a soli 22 anni e celebrata ora da un’antologica a Palazzo della Ragione (già allestita a Siena a inizio anno e rivisitata in questa edizione), ha prodotto opere impregnate di continui riferimenti ai grandi autori che l’hanno influenzata nella sua precoce carriera.
Inizia a fotografare a soli 13 anni, concentrandosi fin da subito su se stessa attraverso autoscatti realizzati in ambienti spogli e squallidi. Si fotografa, dice, per ragioni di convenienza, in quanto è un soggetto sempre disponibile. Studentessa che i genitori assecondavano nella sua passione, non aveva tra l’altro le disponibilità economiche per permettersi di pagare modelli da inquadrare. Ma in questa affermazione scherzosa era celata una verità ben più profonda e cruda: la mancanza di comunione con gli altri la portò a cercare pretesti per un dialogo con il suo io, con la sola persona che poteva esattamente comprendere quale risultato l’artista volesse raggiungere. Francesca Woodman nacque nel 1958 a Denver e crebbe in una famiglia di artisti: il padre Gorge era un pittore e un fotografo, la madre Betty una ceramista. Frequentò la Rhode Island School of Design dove si avvicinò alla più giovane delle arti visive e ai grandi maestri dell’obiettivo. Frequentò molto l’Italia e gli ambienti artistici che la animavano tra gli anni Settanta e Ottanta, in particolare la corrente della Transavanguardia.
Fino al 24 ottobre saranno esposte 116 immagini e cinque video. Lavorava sulle sfocature, in interni domestici, usando luci che trasformarono la figura in una specie di apparizione evanescente. Il cavo che a quei tempi si usava per l’autoscatto è spesso visibile, di proposito non nascosto, a sottolineare ulteriormente questa ricerca maniacale di intimità. I ritratti la vedevano spesso nuda, il suo corpo adolescente vulnerabile e impotente di fronte alla società, alla fatica stessa di vivere che la portò a suicidarsi gettandosi da un palazzo di New York in un giorno freddo d’inverno.
La Woodman si guarda, si nasconde, rappresentava sempre e solo se stessa attraverso attraenti messe in scena, narrazioni, emozioni estetiche che finivano per sconfinare nell’angoscia, nelle paure che la inseguivano. Non è un caso che il volto sia assente, sostituito da ombre, tagliato dalle inquadrature o coperto da maschere, dai capelli, dalla posizione assunta. Alcune pose sono teatrali, altre in movimento o immersa nella natura, altre ancora presentano i segni tipici di una femminilità un po’ convenzionale e stereotipata, dove lei modella è contornata da pochi oggetti come vecchi mobili, specchi, tappezzerie, qualche abito, concepiti come feticci.
La sua carriera durata meno di un decennio e sviluppatasi negli Settanta le è servita per parlarci di solitudine e isolamento, di nostalgia e illusioni, di contraddizioni che lei stessa faticava ad accettare. Ascoltando il suo personale narcisismo, abbandonandosi a volte anche all’ironia, e cercando una propria identità, faceva esperimenti. Aveva creduto di trovare nell’arte una via d’uscita o qualche remota certezza. Ma ha concluso il suo percorso finendo in una di quelle drammatiche storie di cronaca nera che Weegee immortalava facendo lampeggiare il suo flash sulle strade della Grande Mela.
Barbara Silbe (tratto da “Il Giornale”, 7 agosto 2010)